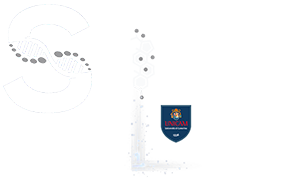Storie scientifiche - Tutto arriva a chi sa aspettare

Il ruolo dell’attesa nella scoperta scientifica veste capitale importanza, ma spesso viene trascurato. Attraverso tre brevi storie racconteremo quando questo elemento sia cruciale e rivesta un ruolo attimo all’interno della ricerca e nel progresso scientifico.
La storia della scienza è disseminata di scoperte che hanno impiegato anni, se non decenni, per affermare la propria forza e veridicità all’interno della comunità scientifica.
Giovanni Jona-Lasinio ha detto [1]:
“Le novità sono spesso difficili da assorbire e dire le cose troppo in anticipo può risultare controproducente perché molti non capiscono. Si può passare vicino a qualcosa che rappresenta una svolta senza accorgersene.”
La prima storia, forse la più famosa, riguarda lo scienziato britannico Peter Higgs e l’attesa di 48 anni prima che venisse ufficializzata la scoperta della particella che porta il suo nome. Nel 1964 Higgs scrisse un articolo dove esponeva le sue idee su un meccanismo in grado di conferire massa alle particelle elementari. Come ricordò lui stesso [2]:
“Mezza dozzina di persone erano coinvolte nella teoria verso il 1964. Se parliamo dell’intera struttura teorica, sicuramente coinvolge sei persone, che si sono divise il premio Sakurai nel 2010. Sono Robert Brout, François Englert, me stesso, Gerald Guralnik, Carl Hagen e Tom Kibble. Ma c'erano altre persone coinvolte in precedenza, in una certa misura. Voglio dire, non è che l'abbia inventato io- il bosone di Higgs- come parte della teoria, ma ho sottolineato la sua presenza in seguito al rifiuto della prima versione del mio articolo.”
Infatti, la prima versione dell’articolo, inviata a Physics Letters venne contestata in alcuni punti e rifiutata per la pubblicazione. Nella sua Nobel Lecture Higgs ricordò che i teorici pensavano che il suo lavoro non avesse alcune rilevanza nel campo della fisica delle particelle. Dopo qualche settimana, Higgs estese i suoi risultati arrivando alla fine del suo lavoro trovò una risposta incredibile: la rottura della simmetria elettrodebole avviene in conseguenza di un campo prodotto da un nuovo bosone dotato di massa [3].
L’idea non venne presa inizialmente in considerazione e lo stesso Higgs ammise che il suo articolo e quello Brout di Englert vennero inizialmente ignorati. Fortunatamente i tre fisici riuscirono a trovare l’appoggio di Stevn Weinberg (uno dei padri della teoria unificata dell’interazione debole ed elettromagnetica, vincitore del Nobel nel 1979) che iniziò a citare i loro lavori nei suoi articoli e a menzionare il “meccanismo di Higgs”.
Quando il giovane studente Gerard 't Hooft, dopo mesi di calcoli molto laboriosi e complessi, riuscì nel 1972 a dimostrare che la teoria era calcolabile, si iniziò ad accettare l’idea del Modello Standard e, con esso, la soluzione proposta da Higgs, Brout ed Englert. Soltanto nel 2012 il CERN comunicò [4] con un semplice “I think we have it”- penso che lo abbiamo trovato- che il bosone di Higgs era stato finalmente individuato. Così, nel 2013, l'Accademia Reale Svedese delle Scienze assegnò il Premio Nobel per la Fisica a Peter Higgs e al belga François Englert, "per la scoperta teorica di un meccanismo che contribuisce alla nostra comprensione dell’origine della massa delle particelle subatomiche, e che di recente è stato confermato, attraverso la scoperta della particella fondamentale, dagli esperimenti ATLAS e CMS al CERN del Large Hadron Collider (LHC)”.
Per introdurre il secondo protagonista della nostra storia dobbiamo fare affidamento alla definizione che André Weil, fratello della filosofa Simone e autorevole matematico, dava proprio di matematico, cioè: si può definire matematico soltanto chi ha scoperto almeno un nuovo teorema. Questo ci aiuta a introdurre. Kiyoshi Itô che nel 1987 ha vinto il premio Wolf per la creazione del calcolo differenziale e integrale stocastico. Un processo stocastico descrive sistemi che evolvono nel tempo in modo probabilistico e non deterministico. La loro origine affonda le radici nello studio del moto Browniano, cioè il ovimento irregolare e apparentemente casuale di particelle di polline in sospensione acquosa, osservato per la prima volta dal botanico Robert Brown nel 1827. Fu Einstein che nel 1905 formalizza il fenomeno attraverso equazioni di diffusione
Il quadro teorico rigoroso fu sviluppato da Norbert Weiner definendo i processi di Wiener e la misura di Wiener fornendo così il prototipo di processi stocastici continui. Parallelamente , Paul Lévy negli anni ’30 e ’40 studiò una classe più generale di processi (processi di Levy) sono caratterizzati da incrementi indipendenti e stazionari.
La formalizzazione assiomatica della probabilità ad opera di Andrej Kolmogorov e lo sviluppo della teoria delle martingale da parte di Joseph Doob consolidarono le basi matematiche ma il salto concettuale definitivo si deve proprio a Itô. Nei suoi Selected Papers [5] ci dono una panoramica di quegli anni:
“Ero affascinato dai ragionamenti della matematica pura. Giocherellando, mi avvicinai ai processi stocastici attraverso la meccanica statistica, In quel periodo, quando la teoria della probabilità non era popolare in Giappone, mi sentivo piuttosto isolato. Mi occorsero alcuni anni per realizzare compiutamente le mie intuizioni.”
Fu proprio dopo aver letto il libro di Kolmogorov che si convinse che la teoria della probabilità potesse essere sviluppata in termini di teoria della misura, guadagnandosi l’appellativo di “il Lebesgue dell’integrazione stocastica” (facendo riferimento al matematico francese Henri Lebesgue che generalizzò il concetto di integrazione di Riemann). Facendo affidamento ancora una volta alle sue parole:
“Pubblicai quel lavoro in giapponese su una rivista ciclostilata dell’Università di Osaka (1942) [6] che era nata per incoraggiare i giovani matematici giapponesi a condividere le proprie idee. A quanto so, nessuno lesse l’articolo con attenzione quando uscì, tranne il mio amico Maruyama. Seppi poi che lo aveva studiato in un campo militare dove era stato arruolato durante la Seconda Guerra Mondiale. Dovetti rinviare di alcuni anni la stesura della generalizzazione del mio lavoro sulle equazioni differenziali stocastiche. Quando lo completai, mi resi conto che in Giappone, a causa della scarsità di carta nel difficile dopoguerra, nessuna rivista avrebbe potuto pubblicare un testo così esteso. Lo inviai al Prof. Doob pe sondare una possibile pubblicazione negli Stati Uniti. Fu grazie alla sua generosa mediazione che il lavoro fu pubblicato nel 1951 [7].”
L’accoglienza riservata alle scoperte di Itô dai probabilisti europei e americani non fu subito entusiastica. Nel ricevere il Kyoto Prize nel 1998, trovò un’elegante metafora per spiegare la bellezza nelle strutture matematiche [8] e di come queste possano essere apprezzate:
“Nelle strutture matematiche costruite con precisione, i matematici trovano lo stesso tipo di bellezza che altri trovano in brani musicali o in architetture maestose. Tuttavia, quando proposi per la prima volta le equazioni differenziali stocastiche, il mio articolo non attirò l’attenzione. Passarono più di dieci anni prima che altri matematici iniziassero a leggere i miei ‘spartiti’ e a suonare la mia ‘musica’. Sviluppando i miei ‘spartiti originali’ in una ‘musica’ più elaborata, i ricercatori hanno contribuito enormemente al suo sviluppo.”
Bruno Pontecorvo, eminente fisico italiano, allievo prima e poi collaboratore di Fermi, è stato uno dei pionieri nel campo della fisica dei neutrini. In alcuni suoi ricordi scrisse [9]:
“È difficile trovare un caso in cui la parola «intuizione» caratterizzi un’impresa umana meglio che nel caso dell’invenzione del neutrino da parte di Pauli.”
Verso la seconda metà degli anni Venti c’era una difficoltà ad interpretare un risultato sperimentale noto: lo spettro continuo del decadimento β. Questo descrive l’emissione spontanea da parte di un nucleo di un elettrone, trasformando un elemento chimico in un altro. La fisica classica prevedeva che, se in questo tipo di decadimento partecipassero solo due corpi, nucleo ed elettrone, quest’ultimo doveva essere messo sempre con un’energia ben definita dettata da una legge inviolabile della fisica, cioè il principio di conservazione dell’energia. Gli esperimenti mostravano che questa energia non era costante, ma variava in modo continuo tra zero e un valore massimo. Erano aperte allora due possibilità teoriche:
Il principio di conservazione è valido solo statisticamente nei processi di decadimento β.
La conservazione dell’energia è valida in ogni singolo processo, ma insieme all’elettrone viene emessa anche un’altra radiazione che sfugge all’osservazione e che corrisponderebbe a una nuova particella neutra.
Nel 1930 Pauli elaborò uno die più importanti contributi al progresso della fisica: l’esistenza del neutrino, che descrisse trent’anni dopo come “lo stupido figlio della mia crisi esistenziale” [10]. Questo perché le notizie relative a questa ipotesi risalivano alla settimana esatta del suo divorzio. Ma è celebre quella lettera del 4 dicembre 1930 che inviò ai partecipanti di un congresso di fisica nucleare a Tubinga, che recita [11]:
“Cari Signori e Signore Radioattivi, di fronte alle statistiche ‘sbagliate’ dei nuclei N e Li-6, nonché dello spettro β continuo, sono ricorso a una soluzione disperata nel tentativo di salvare il ‘teorema dello scambio’ della statistica e la legge di conservazione dell’energia. L’ipotesi è che nei nuclei possano esistere particelle elettricamente neutre che propongo di chiamare neutroni.”
Nel 1932, dopo la scoperta da parte di James Chadwick di quella particella che prese il nome di neutrone, Enrico Fermi e Edoardo Amaldi durante una conversazione proposero giocosamente di aggiungere il suffisso -ino alla particella di Pauli. Uno dei primi indizi dell’esistenza del neutrino giunse a Zurigo verso la fine del 1953. Per celebrare l’evento Pauli e un gruppo di fedeli scalarono l'Uetliberg sopra Zurigo. Durante la discesa, quella sera tardi, racconta William Barker, “Pauli era un po' traballante per il vino rosso bevuto a cena”. Così Barker e un altro accompagnatore lo presero sotto braccetto e cercarono di fargli da appoggio. Ancora nei ricordi di Barker [12]:
“Quanto eravamo circa a metà strada, Pauli si risolve a me con un commento di cui farò per sempre tesoro: «Ricorda Barker, tutte le cose buone arrivano all’uomo che è paziente».”
La prova finale dell’esistenza e della rivelazione del neutrino tardò ad arrivare. In una lettera del 14 giugno del 1956 Frederick Reines e Clyde Cowan scrissero un telegramma a Pauli:
“Siamo lieti di informarti che abbiamo individuato con certezza i neutrini osservando il decadimento beta inverso dei protoni. La sezione d’urto osservata concorda bene con quella prevista.”
Pauli il giorno dopo rispose [13]:
“Grazie per il messaggio. Tutto arriva a chi sa aspettare.”
Per concludere questa rassegna di storie, vorrei citare Carlo Bernardini, uno dei protagonisti del rilancio della fisica italiana degli anni ’50-’60 del Novecento, nel suo libro “Fisica vissuta” [14]:
“Oggi, quando ormai quel poco che potevo fare l’ho fatto, e mi avvio alla conclusione generale, ho un passato da raccontare: ma questo, sia ben chiaro- come lo è a me stesso- è il passato di un fisico “normale” che molti potranno giudicare mediocre, o comunque non geniale. Come me ce ne sono tanti; eppure, qualche diritto a fare la storia lo abbiamo, nel senso che, specie vivendo in un mondo che adora i geni come usava con i semidei, i “comuni mortali” hanno talvolta coscienza dei loro limiti e, perciò, bisogno di consolazione. La Fisica progredisce con i bagliori delle grandi idee, ma anche con la moltitudine delle fiammelle di ideuzze, che non danno fama ma rischiarano il panorama.”
Note:
[1] R. Giustozzi, G. Jona-Lasinio Intervista a Giovanni Jona-Lasinio (2025) https://scienzaelode.unicam.it/intervista-giovanni-jona-lasinio.
[2] M. Durrani Peter Higgs didn’t like talking about himself. Here’s what he told us about CERN, collaboration and his career interview in PhysicsWorld (2024).
[3] Peter W. Higgs Broken symmetry and the Masses of Gauge Bosons Phys. Rev. Lett. 13, 508 (1964).
[4] https://www.youtube.com/watch?v=0CugLD9HF94
[5] Kiyosi Itô Selected Papers Edited by Daniel W. Stroock, S.R.S. Varadhan. Spinger-Verlag (1987).
[6] K. Itô, Differential equations determining a Markoff process (in Japanese), Journ. Pan-Japan Math. Coll. 1077 (1942); English translation in Kiyosi Itô Selected Papers, pp. 42-75, Springer (1986).
[7] K. Itô, On stochastic differential equations, Mem. Amer. Math. Soc 4, 1-51 (1951).
[8] K. Itô, My Sixty Years along the Path of Probability Theory. Kyoto Prize Lecture (1998).
[9] B. Pontecorvo The infancy and youth of neutrino physics: some recollections Journal de Physique Colloques, 1982, 43 (C8).
[10] Abraham Pais Ritratti di scienziati geniali. I fisici del xx secolo traduzione di Stefano Ravaioli. Bollati Boringhieri (2012).
[11] Letter to Lise Meitner (1930). Credits: Pauli Letter Collection, CERN.
[12] Charles P. Enz No Time to be Brief. A scientific biography of Wolfgang Pauli Oxford University Press (2002).
[13] http://cds.cern.ch/record/83513?ln=it
[14] Carlo Bernardini Fisica vissuta Codice Edizioni (2006).