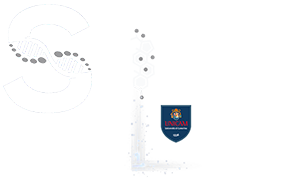“Sembrava avere il dono di trasformare in oro ogni problema che studiava.” [1]
Con la morte di Chen Ning Yang scompare uno degli ultimi grandi protagonisti dello sviluppo della fisica delle particelle e delle alte energie. Nel corso della sua carriera ha rimodellato la fisica teorica moderna, combinando una straordinaria intuizione fisica con l’eleganza matematica.
Figlio di un professore di matematica, Yang nacque e si formò in Cina, dove studiò all’Università Associata del Sudovest, conseguendo la laurea di primo livello nel 1942 sotto la guida di Ta-You Wu, con una tesi sull’applicazione della teoria dei gruppi alla spettroscopia molecolare. Proseguì poi con un Master nei due anni successivi, questa volta studiando con Wang Zhuxi sulla meccanica statistica. Ricordò sempre come le due direzioni di ricerca che gli erano state indicate da Wu e Wang, la simmetria e la meccanica statistica, fossero rimaste le linee guida di tutta la sua carriera.
Di quegli anni ricordò [2]:
“Durante la guerra, la mia famiglia si trasferì a Kummig, nel sud-ovest della Cina, e io frequentai la Xinan Lianda (l’Università Associata del Sud-Ovest). In quel periodo, era combinazione di tre delle più prestigiose università cinesi. I professori erano tra gli studiosi più importanti della Cina di allora. Riflettendo sui miei anni lì, provo una profonda gratitudine. L’università aveva però dei grandi difetti: le aule erano estremamente scomode, i tetti spesso perdevano e le finestre non si chiudevano bene. Il pavimento era di terra battuta e, dopo anni di utilizzo, si erano formate molte buche. La situazione era difficile, ma il nostro spirito era straordinario. Tutti prendevano i corsi molto seriamente. E ho spesso riflettuto su quell’esperienza, concludendo che le basi di tutto il mio lavoro successivo furono gettate in quegli anni a Kunming.
Affrontavamo anche grandi difficoltà personali. Per esempio, capitava di nasconderci nei fossati a causa dei continui bombardamenti aerei. Ricordo che un giorno del 1940 ci fu un grande raid. Avevo portato due miei fratelli minori in campagna. Vedemmo arrivare i bombardieri giapponesi che sganciavano le bombe, e poi vedemmo un incendio. Quando l’allarme cessò, tornammo verso la città. La casa in cui abitavamo era stata colpita. Ricordo ancora vividamente che, dopo pochi giorni, tornai con mio padre e cominciammo a scavare tra le macerie. […]
Rimasi all’università più a lungo della maggior parte degli studenti, dal 1938 al 1944. A quel tempo in Cina non esisteva ancora il dottorato di ricerca.”

In quegli anni Yang iniziò ad appassionarsi a un certo modo di fare fisica, una predilezione che lo portò ad ammirare figure del calibro di Albert Einstein, Paul Dirac ed Enrico Fermi. Ancora Yang raccontò [2]:
“Ho ricevuto un’ottima formazione in fisica. Non solo perché avevo imparato la parte tecnica ma soprattutto perché avevo sviluppato un personale gusto per la fisica. Imparai ad apprezzare certi articoli e a non apprezzarne altri. Questo non significa che i lavori che non mi piacevano fossero di scarso valore: potevano essere lavori molto importanti, ma semplicemente non mi piacevano né l’argomento trattato né i metodi usati. È molto importante, nel processo di maturazione di un giovane studioso, sviluppare un gusto personale. Questo non vale solo per uno scrittore, un artista o un musicista, ma anche per uno scienziato.
È un’interazione tra l’oggetto di studio, che è oggettivo, e il giudizio soggettivo del ricercatore; ed è proprio in questa interazione che è importante sviluppare un punto di vista specifico. Uno studente che non lo acquisisce non può diventare un vero ricercatore, perché deve sviluppare un proprio giudizio di valore, che non è sempre corretto, ma è indispensabile averne uno. Se poi scopre che alcuni giudizi erano sbagliati, quel processo stesso gli insegnerà qualcosa e lo porterò ad aggiustare i propri giudizi in seguito.”
Nell’estate del 1944, Yang vinse un concorso per una borsa di studio per recarsi negli Stati Uniti. Tra l’autunno dello stesso anno e l’estate del ’45, mentre insegnava in una scuola media in attesa dei documenti per la partenza, si immerse completamente nello studio della teoria dei campi e in particolare dell’articolo di rassegna di Wolfgang Pauli.
Arrivò nel 1945 in America, speranzoso di studiare sotto la guida di Enrico Fermi ma rimase molto deluso nel constatare che il fisico italiano aveva lasciato la Columbia University e nessuno sapeva dove fosse. Dopo qualche ricerca apprese che Fermi si sarebbe trasferito presto a Chicago. Qui si immatricolò come studente di dottorato nel 1946, chiedendo a Fermi di scrivere una tesi in fisica sperimentale. Tuttavia, a quel tempo il fisico italiano lavorava all’Argonne National Laboratory che, a quel tempo, non consentiva agli studenti stranieri la partecipazione alle attività di ricerca. In seguito, Fermi raccomandò Yang perché lavorasse alla costruzione di un acceleratore di Cockcroft-Walton da 400 keV. Dopo venti mesi di lavoro la costruzione fu ultimata ma, sfortunatamente, il suo esperimento su quell’acceleratore fallì. Su consiglio di Edward Teller, Yang completò un lavoro teorico già quasi finito e questo articolo fu usato come dissertazione di dottorato.
Yang trascorse poi un anno a Chicago come assistente di Fermi e nel 1949 scrissero un articolo intitolato “Are mesons elementary particles?”. I mesoni π e μ furono scoperti nel 1947 e la maggior parte dei ricercatori credevano che fossero particelle elementari. Nel loro articolo, che portò al cosiddetto “modello di Fermi-Yang”, i due suggerirono che un mesone π potesse essere uno stato legato di un nucleone e di un antinucleone, aprendo di fatto la strada per lo studio della struttura costitutiva degli adroni [3]. Più tardi lo stesso Fermi spese parole di ammirazione nei confronti di Yang, descrivendolo come “un fisico teorico eccezionalmente dotato”. [4]
Nella primavera del 1949 Yang fece domanda per una posizione all’Institute for Advanced Study di Princeton. Robert Oppenheimer, che era l’allora direttore, accettò descrivendo il lavoro di Yang come dimostrazione di “grande immaginazione e semplicità concettuale di base, nonché di considerevole capacità analitica. È inoltre caratterizzato da buon gusto, sobrietà e giudizio critico, davvero notevoli in uno scienziato così giovane.” Alla lista dei complimenti si aggiunse anche Eugene Wigner, che lodò Yang scrivendo: “L’utilità di uno scienziato deriva da due funzioni: dalla sua ricerca e dalla sua capacità di comprendere e comunicare le scoperte dei suoi colleghi. Yang eccelle in entrambi questi aspetti.” [4]
A Princeton rimase dal 1949 al 1966, anni che furono i più produttivi della sua vita scientifica. Nella primavera del 1965 Oppenheimer disse a Yang che stava per lasciare il posto di Direttore e che avrebbe raccomandato lui come suo successore. Yang declinò l’offerta scrivendo a Oppenheimer:
“Non è affatto certo che io possa essere un buon direttore, mentre è piuttosto certo che non mi piacerebbe la vita da direttore.” [3]
Tuttavia, nel 1966 decise di accettare la posizione di Albert Einstein Professor all’Università di Stony Brook e di diventare così il primo direttore del neonato istituto di fisica teorica, che oggi porta il suo nome. Qui rimase fino al 1999. Nel 1971 tornò a visitare la Cina, diventando uno dei promotori degli scambi culturali tra Cina e Stati Uniti, compiendo molti passi in questa direzione.
Ci sono molti libri e fonti autorevoli che danno una descrizione dei suoi lavori come i Selected Papers [5] e altri che invece rendono omaggio a un’opera monumentale come la teoria di Yang-Mills [6]. Descrivere il lavoro scientifico di Yang risulta un’opera pressoché impossibile visto che i suoi contributi alla fisica teorica coprono un ampio spettro, dalla fisica delle particelle alla meccanica statistica alla fisica della materia condensata. Come riportato in un report che ricopre un intervallo temporale che val dal 1948 al 1953 [7]:
“Il lavoro di Yang ha toccato così tanti temi e con tale successo che una sintesi risulta inadeguata.”
Il suo nome è, però, associato a due delle idee centrali di quello che sarebbe poi diventato il Modello Standard: la teoria dei campi di gauge non abeliani, chiamata poi la teoria di Yang e Mills e la violazione della parità nelle interazioni deboli.
Nel 1953, mentre si trovava al Brookhaven National Laboratory, Yang formulò insieme a Robert Mills un’estensione della teoria dell’elettrodinamica quantistica, passando dal gruppo di gauge U(1) al gruppo SU(2). Un ‘gruppo di gauge’ descrive una simmetria di una legge fisica: applicando determinate trasformazioni, le equazioni di nostro interesse rimangono invariate.
Il gruppo U(1) rappresenta le rotazioni nel piano complesso ed è abeliano, quindi le trasformazioni commutano, cioè l’ordine in cui vengono applicate non cambia il risultato. È il gruppo che descrive la simmetria della teoria dell’elettromagnetismo. Qui la trasformazione di gauge corrisponde a modificare la fase della funzione d’onda delle particelle, moltiplicandola per un numero complesso di modulo 1. Il gruppo SU(2), invece, rappresenta le rotazioni in uno spazio complesso bidimensionale. È non abeliano, il che vuol dire che l’ordine in cui vengono applicate le trasformazioni influisce sul risultato. Tale proprietà rende tutto molto più complesso da studiare. Come regola generale, l’invarianza di gauge comporta l’esistenza di un campo vettoriale, il campo di gauge. A ogni campo è associata una particella, detta bosone di gauge, che media l’interazione corrispondente: ad esempio per l’elettromagnetismo abbiamo il fotone, mentre nel caso di SU(2) abbiamo W+, W-, Z0 che governano l’interazione debole.
Già durante il dottorato all’Università di Chicago, Yang era affascinato dalla relazione tra la conservazione della carica e l’invarianza rispetto alle trasformazioni di fase. Di quei giorni ricordò [5]:
“Durante i miei studi rimasi impressionato dal fatto che l’invarianza di gauge determinasse tutte le interazioni elettromagnetiche. Mentre ero a Chicago cercai di generalizzare questo concetto alle interazioni di isospin. Cercai poi di definire le intensità di campo in quello che sembrava una naturale generalizzazione dell’elettromagnetismo. Questo però portò a un vicolo cieco e fui costretto ad abbandonare l’idea. Tuttavia, la motivazione di fondo rimaneva attraente, e ci tornai più volte nei successivi anni, ma rimasi bloccato nel medesimo punto. Il ripetersi di fallimenti di fronte a idee apparentemente valide è, naturalmente, un’esperienza comune a tutti i ricercatori. La maggior parte di queste idee viene alla fine scartata o accantonata, ma alcune persistono e possono diventare delle vere e proprie ossessioni. Occasionalmente, un’ossessione si rivela alla fine qualcosa di valido.”
In quegli anni si stavano scoprendo sempre più particelle e le loro interazioni apparivano estremamente complesse. Yang si convinse che dovesse esistere un principio generale per spiegare tali interazioni. Nel 1953, mentre era al Brookhaven National Laboratory, Yang iniziò una collaborazione con Robert Mills, che stava finendo il suo dottorato alla Columbia University. Insieme pubblicarono nel 1954 il celebre articolo “Conservation of Isotopic Spin and Isotopic Gauge Invariance”. In esso introdussero il concetto di invarianza di gauge non abeliana e la corrispondente teoria di campo di gauge, oggi nota come teoria di Yang-Mills. Fu un contributo di portata epocale, che gettò le basi teoriche dell’intera moderna fisica delle particelle.
In natura esistono quattro tipo di interazioni: forte, elettromagnetica, debole e gravitazionale. Oggi sappiamo che i campi che trasmettono le prime tre sono tutti campi di Yang-Mills e costituiscono il Modello Standard della fisica delle particelle. La Natura ha sorprendentemente scelto di utilizzare i gruppi di simmetria di gauge più semplici per descrivere queste interazioni: U(1) x SU(2) x SU(3). I campi di Yang-Mills SU(3) descrivono le interazioni forti, mediate dai gluoni, nella teoria chiamata cromodinamica quantistica (abbreviata QCD). I campi di Yang-Mills SU(2) descrivono invece le interazioni deboli, che si unificano con i campi di Maxwell U(1) ed insieme sono responsabili delle interazioni elettrodeboli unificate. Una teoria quantistica dei campi è stata formulata e prende il nome di dinamica quantistica dei sapori (QFD). In essa, i campi quantistici di Maxwell (U(1)) restano i “collanti” delle interazioni elettromagnetiche, mentre i campi quantistici di Yang–Mills (SU(2)) costituiscono i “collanti deboli” delle interazioni deboli. [8]
Durante questa unificazione, i quanti dei campi SU(2), inizialmente senza massa, acquisiscono massa attraverso il meccanismo di Higgs, trasformandosi nei bosoni W⁺, W⁻ e Z⁰.
I quanti del campo U(1), invece, restano senza massa dato che sono i fotoni che trasmettono l’interazione elettromagnetica su lunghe distanze.
È proprio questo pezzo del puzzle, teorizzato da Higgs nel 1964 e dimostrato sperimentalmente al CERN nel 2012, che mancava a Yang. Infatti, nel loro lavoro si resero conto di non essere in grado di stabilire quale dovesse essere la massa della particella di gauge da loro introdotta.
A tal proposito c’è un aneddoto che Yang stesso ha raccontato in diverse occasioni. Nel febbraio ’54, Oppenheimer lo invitò a Princeton per tenere un seminario sulla teoria di Yang-Mills. Tra il pubblico sedeva anche Wolfgang Pauli che univa una profonda e completa conoscenza della fisica a un carattere pungente. Yang fece in tempo a scrivere la prima formula sulla lavagna che Pauli lo interruppe chiedendo: “Qual è la massa di questo campo?”. Yang rispose che non lo sapevano e riprese la presentazione. Ma poco dopo Pauli pose di nuovo la stessa domanda. Questa volta Yang rispose che si trattava di un problema molto complicato, su cui avevano lavorato duramente ma su cui non vi erano conclusioni definitive. Ci facciamo raccontare la reazione dallo stesso Yang che scrisse [5]:
“Ricordo ancora la sua replica: «Questa scusa non è sufficiente.»”
Ripensando ai giorni di quella scoperta, Mills scrisse [3]:
“Yang, che in più di un’occasione ha dimostrato la sua generosità verso i giovani fisici all’inizio della loro carriera, mi parlò della sua idea di generalizzare l’invarianza di gauge e ne discutemmo a lungo. Avendo una certa esperienza in elettrodinamica quantistica, riuscii a dare qualche contributo alla discussione, in particolare riguardo alle procedure di quantizzazione, e in piccola parte nell’elaborazione del formalismo; tuttavia, le idee fondamentali furono di Yang.”
La teoria di Yang e Mills ha avuto anche un enorme impatto in matematica. A partire dagli anni ’70, i matematici ne riconobbero la struttura geometrica. Un risultato particolarmente significativo è rappresentato dal teorema di Donaldson. Utilizzando particolari soluzioni delle equazioni, note come istantoni, su varietà Riemanniane compatte a quattro dimensioni, Simon Donaldson scoprì che esistevano strutture differenziabili non standard nello spazio euclideo a quattro dimensioni. Per tale risultato fu premiato con la Medaglia Fields nel 1986.
L’importanza della teoria di Yang–Mills in matematica è tale che la sua formulazione rigorosa e la dimostrazione dell’esistenza di un “gap di massa” (cioè una differenza non nulla tra lo stato fondamentale e il primo livello eccitato) costituiscono oggi uno dei sette Problemi del Millennio del Clay Mathematics Institute e la cui risoluzione ha un premio in denaro di un milione di dollari.
Yang ha vinto il premio Nobel nel 1957 insieme a Tsung-Dao Lee per un altro fondamentale lavoro, quello della violazione della parità nelle interazioni deboli. La motivazione recita: “per la loro penetrante indagine delle cosiddette leggi di parità, che ha portato a importanti scoperte per quanto riguarda le particelle elementari”. Ma questa è una storia che ci porterebbe troppo lontano. D’altronde, come già detto, qualsiasi tentativo di sintesi del suo lavoro sarebbe inadeguata.
Note
[1] Ling-Lie Chau Yang’s Pyramid in “Chen Ning Yang, A Great Physicist of the Twentieth Century” Editors C.S. Liu e S.T. Yau (1992); Ling-Lie Chau “Almost Every Problem He touched Eventually Turned Into Gold Proceedings Trim Size (2008).
[2] Chen Ning Yang Some Reminiscences Lecture delivered at the National University of Singapore (1987).
[3] Bing-An Li e Yuefan Deng Chen Ning Yang; Paolo Rossi Centesimo anniversario della nascita di Chen Ning Yang. Giornale di fisica Vol. LXIII, N.1. (2022).
[4] Celebrating Chen Ning Yang at 100 Institute for Advanced Study, Source Shelby White and eon Levy Archives Center (2022).
[5] Chen Ning Yang Selected Papers (1945-1980) with commentary World Scientific Series in 20th Century Physics (2005 Edition).
[6] Report of the Director 1948-1953. The Institute for Advanced Study Princeton.
[7] 50 Years of Yang-Mills Theory edited by Gerardus ‘t Hooft World Scientific (2004).
[8] Ling-Lie Chau Yang-Mills Theory at 60: Milestones, Landmarks and Interesting Questions Proceedings of Conference in 60 Years of the Yang-Mills Theory p.79-109 (2016).